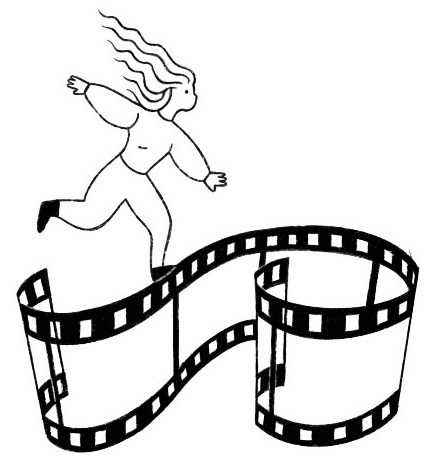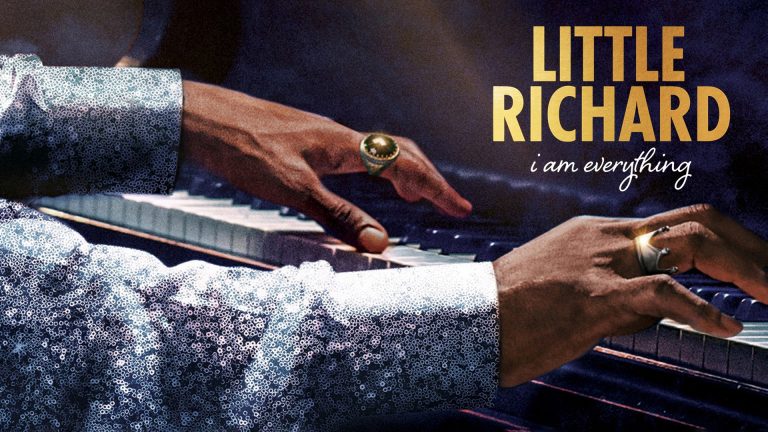Un drone sorvola dall’alto una città moderna dell’Irlanda. Dai colorati container del porto, ci porta lungo le sue strade, trai suoi palazzi e monumenti. Si abbassa, per avvicinarsi ad un muro di mattoni rossi. Sale. Portandoci nell’estate del 1969, dove un iper-digitalizzato bianco e nero ci porta nel passato. Giù verso la gioia, accompagnati dalle note di Van Morrison. Questo l’inizio di Belfast, film presentato in anteprima italiana alla passata edizione di Alice nella città e in attesa di scoprire (domenica 27 marzo) se e quanti Oscar porterà a casa dopo aver ottenuto ben 7 nomination. Ed è anche il lavoro con il quale il suo regista, Kenneth Branagh, accompagna lo spettatore lungo un viaggio nel suo passato, nella sua infanzia e negli anni che hanno caratterizzato l’inizio della sanguinosa guerra tra protestanti e cattolici in Irlanda.
Non completamente un’autobiografia (seppur siano diverse le similitudine tra la vita del giovane protagonista e quelle del regista), ma indubbiamente un sentito omaggio di Kenneth Branagh non solo alla spensieratezza giocosa della sua infanzia irlandese prima del trasferimento in Inghilterra. In Belfast troviamo anche la voglia di non dimenticare una delle pagine più buie della storia europea a cavallo tra gli anni Settanta e Novanta, che ha profondamente sconvolto il popolo irlandese. In questo senso, ci sembrano da sottolineare le frasi con le quali il regista lascia la sua dedica.
Per quelli che sono restati. Per quelli che sono partiti. Per tutti quelli che si sono persi.
I membri della famiglia Branagh, protestanti della classe operaia, sono tra coloro che sono partiti. Spaventati dalla violenza che imperversava per le strade di Belfast e desiderosi di cercare un luogo in cui migliorare le proprie condizioni di vita. Un abbandono delle proprie origini ed un retaggio di immigrazione che hanno profondamente influenzato il regista negli anni della sua formazione. Dall’iscrizione – voluta dalla madre – ad un corso di dizione sin dalla giovane età, per proteggersi dagli atti di bullismo di cui era vittima a causa del suo marcato accento irlandese, alla voglia di eccellere in quella che è la culla della cultura inglese: il teatro e le trasposizioni (sia teatrali che cinematografiche) dell’opera shakespeariana.
Tornando (anche) alla sceneggiatura (l’ultima nel 2006, per Il flauto magico), Kenneth Branagh confeziona un film intimo, nel quale, da una parte, ci invita a guardare al mondo con gli occhi del suo giovane protagonista; dall’altra, ci mostra come quello sguardo fanciullesco sia costretto troppo presto a maturare di fronte alla spietatezza degli adulti e del loro mondo fatto di ingiustizie, conflitti ed egoismi.

Succede così che in Belfast Kenneth diventi Buddy, un bambino di 9 anni gioioso, curioso ed amato da tutti. Il suo sorriso, i suoi giochi e scorribande innocenti con gli amici e l’affetto di tutti gli abitanti della tranquilla strada in cui vive. Buddy è un bambino felice ed amato. Protetto dai genitori e dal fratello ed amorevolmente accudito dai nonni, confidenti e premurosi con lui e capaci di diventare suoi maestri di vita. Anche solo insegnandogli qualche trucchetto matematico che gli permetta di superare le verifiche e raggiungere l’ambito banco accanto accanto a Catherine, la compagna di scuola che è anche il suo primo amore. Branagh fa ruotare attorno a lui tutta la narrazione, cercando di presentarlo allo spettatore come l’amico (in un contesto gergale e confidenziale, proprio a questo si riferisce il termine buddy, NdA) che hanno avuto o avrebbero voluto avere. Andando così a cercare di creare un rapporto di empatia diretta tra il pubblico e il protagonista del suo film. Lo fa affidando il ruolo ad un giovanissimo attore, Jude Hill (al suo esordio cinematografico), capace, con la sua genuinità ed innata espressività di offrirci un’interpretazione naturale, ma non per questo non profondamente intensa. Mettendo al centro lo sguardo di Buddy sul mondo, Branagh può permettersi di impostare i suoi dialoghi in modo semplice, diretto. Perché, oltre al protagonista e ai suoi coetanei, tutti i protagonisti sembrano costruire i loro discorsi appositamente per essere compresi da quel bambino ancora così piccolo per poter comprendere i motivi per i quali il suo mondo, nell’arco di una sola estate, venga così drammaticamente sconvolto.
Se le vicende di Buddy e le difficili scelte che la sua famiglia è costretta a prendere ci raccontano il mondo personale del protagonista (e del regista), è il contesto storico e politico in cui si svolge Belfast a rendere ancora più tragico e difficile il racconto che Kenneth Branagh cerca di fare con questo suo film. Come spiegare, senza banalizzarlo, il caos dei Troubles, che ha generato il conflitto nord-irlandese tra protestanti e cattolici e che ha sconvolto e radicalmente modificato gli equilibri nel paese per oltre trent’anni (con appendici che si trascinano fino ai giorni nostri)? Come raccontare quanto la violenza di quegli anni abbia approfittato di una differenza di credo religioso per sfociare in un’aspra contrapposizione ideologica, nascondendo una crisi economica e lavorativa che già da anni stava portando molte famiglie a rifugiarsi in altri stati del Commonwealth? In che modo mostrare la potenza delle bombe, l’arroganza delle retate e dei sistemi intimidatori con cui interi quartieri venivano gestiti e il senso di rassegnazione di molti di fronte ad un mondo che sembrava stesse per crollare?

Non solo Belfast non cerca di nascondere tutto questo, ma lo palesa in tutta la sua brutalità. In tutta l’irruenza che quel conflitto ha generato nella popolazione irlandese e nelle (fino a quel momento) tranquille vite degli irlandesi. E Kenneth Branagh non ha giustificazioni per nessuno. Né per i protestanti, che ci mostra nel linguaggio crudo e fatalista dei sermoni del pastore della missione a cui Buddy e la sua famiglia si reca la domenica. Né per governo inglese, mostrato nel suo colpevole silenzio ed attendismo, convinta che le rivolte in essere avrebbero al massimo portato ad una guerra a bassa intensità, che comunque non avrebbe mai intaccato i confini dell’isola e le sorti del Commonwealth. Branagh lascia che sia la storia a dimostrare quanto questi atteggiamenti e considerazioni siano stati errati e distruttivi.
Il regista, mai prima d’ora così orgogliosamente nordirlandese, vuole mostrarci quali, di fronte a qualsiasi conflitto e contrapposizione ideologica, siano le sole risposte possibili: l’amore e l’affidarsi al bello che ci circonda.

Buddy non avrà paura fino a quando saprà che la sua famiglia sarà con lui. Unita. Le finestre delle case distrutte durante le retate; i muri erti dall’esercito per nascondere il conflitto e rinchiudere gli abitanti nella loro disperazione; gli strozzini che nascondono i loro soprusi con una falsa promessa di protezione. Questo mondo potrà sparire fino a quando il piccolo protagonista potrà vedere i suoi genitori abbracciati in un appassionato ballo. Fino a quando potrà continuare a fare la sua collezione di macchine. Fino a quando potrà accantonare il suo mondo in bianco e nero e rifugiarsi in quello, colorato e fantasioso, che può scoprire sul grande schermo di un cinema o sulle assi di un palcoscenico teatrale. Il bianco e nero di Belfast, infatti, viene solo sporadicamente interrotto da piccoli lampi di vivido colore. Quello delle immagini dei film fantasy e western che tanto appassionano il piccolo Buddy e delle scene da Un canto di Natale a cui assiste insieme all’adorata nonna. Colori che sono anche un richiamo a ciò che sarà, a quello che è destinato ad essere il futuro dello stesso Branagh.
In questo continuo richiamo tra passato e futuro, nel contrasto tra l’amore di una famiglia che può sconfiggere la violenza del mondo che ci circonda e nella volontà di mantenere vivo il legame tra ciò che siamo diventati senza rinnegare ciò che siamo stati sta la forza di Belfast. Una potenza espressa anche dalla nitidezza mai invasiva della fotografia di Haris Zambarloukos (che ben conosce l’immaginario visivo di Kenneth Branagh, avendo collaborato con lui in altri 7 film). Una forza che traspare in ogni nota della colonna sonora interamente ideata da quel Van Morrison a cui è affidata proprio la scena iniziale del film e che confeziona per il film delle musiche travolgenti e strazianti al tempo stesso come solo il brit-blues a cui si affida è in grado di fare. E il regista carica il suo film di tutta l’intensità che un cast di non sempre noti attori (ma tutti provenienti da una grande tradizione teatrale), ma eccelsi interpreti sa dargli. Giocando sul sicuro per le due figure apicali di tutta la narrazione, i nonni di Buddy, non a caso affidati a due grandi attori della tradizione inglese quali Judi Dench e Ciarán Hinds, meritatamente entrambi candidati all’Oscar per il loro ruolo da non protagonisti.
Belfast, sin dalla sua presentazione a Toronto e anche in occasione della recente uscita in sala a provocato contrastanti giudizi da parte della critica. Che ha accusato Kenneth Branagh di non essere stato sufficientemente coraggioso nel prendere una netta posizione nei confronti dei fatti narrati. Ma noi ve ne consigliamo la visione. Perché è imparando a guardare al mondo con gli occhi fanciulleschi di Buddy che torneremo a comprendere la futilità delle nostre convinzioni di rivalsa sull’altro. Ancora di più in momenti in incertezza e con venti di guerra come quelli che stiamo vivendo.