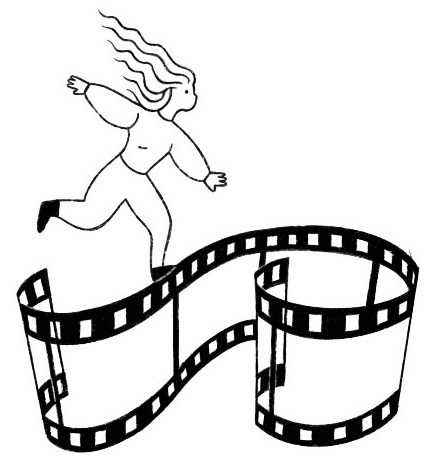Tra i film in concorso al XXI Festival del Cinema di Porretta troviamo anche Spaccaossa, esordio alla regia cinematografica di Vincenzo Pirrotta. Lo abbiamo incontrato prima della proiezione al Cinema Kursaal e dell’incontro con la Giuria Giovani del Festival. Ne è uscita una ricca intervista a tutto campo: tra teatro, cinema dietro e davanti la macchina da presa e quella voglia di raccontare la mostruosità umana come la Palermo dimenticata e dei dimenticati.
Arrivi da una lunga e proficua carriera teatrale, che ti ha formato prima come attore poi come regista. Qual è secondo te oggi il ruolo delle scuole di recitazione?
Per me le scuole servono assolutamente. Chiaramente, la scelta dell’Accademia o della scuola a cui iscriversi è fondamentale. Ci sono tanti lestofanti in giro, che sfruttano i sogni delle persone e, in questo caso, bisogna stare molto più attenti. Io vengo dal teatro, che prevede una formazione molto più rigorosa, anche rispetto a quella per il cinema. Poi, le classi delle Accademie sono come il vino: a volte ti viene la buona annata, altre volte un po’ meno. Però, se un’Accademia sceglie, il talento in rarissimi casi è sprecato. Invece, in giro c’è tutto un mondo di sfruttamento che fa male a tutti.
Questo ultimo periodo per te è stato molto intenso. Andando per gradi, dopo tanti anni di teatro, vissuto e fatto intensamente, sia come attore che occupandoti della regia teatrale (93 regie, tra lirica e teatro), scoprendo anche talenti importanti del teatro siciliano, cosa ti porta a cercare di addentrarti così in profondità nelle storie che poi vai a raccontare e interpretare?
Partiamo dal fatto che, quando mi chiedono che lavoro faccio, rispondo il raccontatore – dovrei dire il contista, ma poi diventa complesso spiegare il senso di questa traslitterazione dal siciliano. Voglio raccontare storie. Ma quelle che mi interessano sono storie che ritengo abbiano saputo prendermi emotivamente, mi abbiano inquietato. Nel farlo, non cerco di essere ruffiano con il pubblico, di piacere a tutti i costi. Se una storia deve fare male, deve fare male. Se deve arrivare al pubblico come un pugno allo stomaco, deve arrivare come un pugno allo stomaco dello spettatore. Non la voglio edulcorare. Questo è stato il tentativo seguito durante tutta la mia carriera. Io ho già scritto l’epitaffio della mia tomba: ha fatto delle proposte. Faccio tentativi: a volte riescono, altre no. Questo vale soprattutto per il teatro civile e sociale – non mi piace rinchiudermi in definizioni, ma così viene chiamato e lo chiameremo – di cui mi sono occupato e per cui ho finora scritto. In questo contesto inserisco anche il mio volermi confrontare con i classici e la mia volontà di incontrare e rapportarmi con il teatro elisabettiano, cercando di coglierne gli aspetti legati al mostro presente nell’uomo. Non a caso, ho sempre scelto dei personaggi che abbiano a che fare con la mostruosità (dal Faust di Marlowe, al Macbeth o l’Otello di Shakespeare).

Tutto questo si è unito e ti ha portato al tuo esordio alla regia cinematografica: Spaccaossa.
Sì. La mia drammaturgia civile, la mia ricerca sulla mostruosità e i demoni che animano l’uomo, combinate all’esperienza fatta con Spaccaossa, mi stanno portando a voler sviluppare una trilogia cinematografica su quello che è il demone del denaro e che, però, coinvolge anche altre nere ed oscure trame dell’animo umano. Quando, per la prima volta, ho sentito di questo caso di cronaca che ha anche avuto una certa eco mediatica, la storia mi è arrivata come un pugno allo stomaco. E visto che, come ho detto prima, se questo succede sento l’esigenza di dover raccontare una storia simile, ho iniziato a scriverla per il teatro. Poi, però, la storia continuava a chiamarmi. Avevo frequentato fino ad allora il cinema sempre da ospite, da attore, e un po’ mi incuriosiva il mezzo. Ma non avevo mai riflettuto sul fatto che potessi passare dall’altra parte, anche se il passaggio, data la mia esperienza nella regia teatrale, è stato morbido. Però queste due anime, quella del racconto civile e del mostro che cercavo nel confronto con il teatro classico, in Spaccaossa si sono incontrate. Perché i personaggi del film sono quasi shakesperiani e se analizziamo, ad esempio, Giovanna, la madre di Vincenzo, troviamo l’archetipo dei grandi tragici shakesperiani.
Sicuramente, troviamo molti elementi della tragedia. Ma anche molto della tradizione siciliana. Guardando il film, si percepisce indubbiamente il tuo legame con il teatro, anche nella scelta di una messa in scena molto asciutta, in cui a parlare sono i tuoi personaggi.
Assolutamente. Perché li ho scritti seguendo una logica, appunto, archetipica. Potremmo definire Spaccaossa una tragedia postmoderna. In cui guardo a quello che ci hanno lasciato i classici, sia elisabettiani che anche greci. Declinandoli, però, in modo pop, anche nell’incontro con la tragedia. Ci sono dei personaggi nel film che sono assolutamente pop, che magari possono essermi stati veicolati da alcuni magisteri cinematografici. Penso, ad esempio, a Fasulina e Biagio, che possono essere dei personaggi che ne ricordano di alcuni tarantiniani. Lì c’è un compendio della mia ricerca, della mia esperienza artistica. Consegno Spaccaossa agli spettatori sentendomi onesto del dare loro un film che, innanzitutto, non vuole giudicare. Semmai, il dito lo punto sullo spettatore. La storia racconta tutto da sé, anche per questo ho voluto quell’asciuttezza di cui abbiamo parlato prima. Ci sono certamente dei carnefici che si approfittano di altri, e sono i membri dell’organizzazione che racconto. Ma chi sono le vittime? Quelle della storia da cui parto sono tutte consenzienti. Sta proprio lì il cortocircuito di quella mostruosità che cercavo. Se non ci fosse questo, non ci sarebbero dubbi sul da che parte stare, invece qui non lo sai. Anzi, ti poni una domanda, che mi sono posto io e che vorrei consegnare ugualmente allo spettatore: quanto ognuno di noi è disposto a farsi mutilare, non solo fisicamente, pur di ottenere qualcosa in cambio? È una domanda che coinvolge la dignità di ognuno di noi. Il confronto con la mostruosità e con questa storia terribile fa male, perché non sai da che parte devi stare e, soprattutto, non puoi impedire che ti coinvolga.

In questo, nel tuo modo di presentare la storia, tu non cerchi empatia tra pubblico e nessuno dei tuoi personaggi. E quello che resta è davvero un dolore che è anche fisico.
È, volutamente, un film senza speranza. Non voglio lasciarla. Perché quando devi raccontare la mostruosità non puoi l’asciare l’alito della speranza. Quando, ad esempio, nella scena di montaggio finale – che, non a caso, ho voluto chiamare il porcile – riprendo questi mostri in un loro momento di umana mostruosità. I due che divorano le interiora in questo locale di street food palermitano che si chiama La Frittola e che riprendo come se fossero delle iene che divorano le carcasse delle loro prede; Francesco che è incurante del sonno della moglie e, mentre si spoglia, non sappiamo che intenzioni abbia nei suoi confronti; la madre di Vincenzo, di cui abbiamo già conosciuto tutta la mostruosità, che semplicemente passeggia nel corridoio per finire in bagno sul water; Michele, che aveva detto stesse andando dalla moglie, ma la troviamo in un letto accanto ad un’altra donna.
È come in certi quadri di Bosch o di Bacon, i pittori della mostruosità. Non la faccio vedere, ma lascio che la si intuisca. Quella scena parte da Luisa che scopre della morte di Mimmo. E tutto sembra tornare indietro. È lì che punto il dito contro lo spettatore. Il canto di Giuni Russo che accompagna tutta questa scena, dice o vos omnes qui transitis per viam, considerate e ditemi che quello che vedete non è dolore simile al mio dolore. È tratto da un brano della Bibbia, ma io lo voglio dire allo spettatore. Chiedergli se quel dolore non sia simile al loro e se riescano a stare seduti tranquilli sulla poltrona. Perché, a volte, quel dolore è vicino a noi e non ce ne accorgiamo o facciamo finta non ci riguardi.

Questa tua ricerca della mostruosità e voglia di rappresentarla come se fossero dei quadri, quanto sei riuscito a renderle anche grazie al fatto di poter contare su Daniele Ciprì come direttore della fotografia, che ha voluto agire per sottrazione e impostare una gamma di colori capace di accompagnare ogni scena del film?
Quello è stato un regalo della vita. Daniele (Ciprì) ha da subito sentito molto questo progetto come se fosse anche suo. La prima volta che ci siamo sentiti, io gli ho chiesto una Palermo irriconoscibile, plumbea, di ghiaccio come quello che i delinquenti che racconto usano come anestetico. Ma ci ho anche tenuto, per fargli capire il senso profondo della mia scelta, a raccontargli un mio ricordo intimo e personale. Quando ero bambino, a Partinico (paesino della provincia di Palermo), il Venerdì Santo c’era la processione del Cristo morto, che usciva dalla Chiesa dell’Opera Santa (che si chiamava così perché davano sepoltura ai condannati a morte). Sul mio modo di voler rappresentare la storia, ha influito molto una cosa che succedeva spesso durante quella processione, che vivevo sempre con una certa inquietudine. Prima dell’uscita della bara del Cristo Morto, usciva la statua dell’Addolorata, con il suo manto nero. In quel periodo dell’anno, la Madonna, portata dai portantini, faceva una specie di eclissi, oscurando il sole. Tutto il popolo era sul sagrato della chiesa, con la statua in alto. Io mi spaventavo. La prima volta è stato proprio un trauma, ma anche altre volte in cui è successo, tornavo a casa con questa inquietudine. Tutto il panorama diventava come di ghiaccio, per pochissimi secondi. Sufficienti a farmi vivere quei momenti come uno dei traumi più forti della mia fanciullezza. A Ciprì ho detto che era proprio quella sensazione che volevo far rivivere nel film. Da lì anche lui ha compreso il senso profondo di quello che ricercavo. Che va oltre la luce e diventa un letto per questa mostruosità.

La tua scelta di raccontare Palermo nasce non solo da dove viene quella storia. Nel film ci restituisci una città completamente nuova dall’immaginario che ce ne siamo fatti. A cosa è dovuta questa scelta.
Volevo raccontare il ventre molle della città. Ho girato in due quartieri in cui Palermo è restata la mia città. Luoghi dimenticati, che ho cercato per la volontà di mostrare il bene che provo verso la mia città non nascondendola anche negli aspetti più crudi. È un qualcosa che già Maresco e Letizia Battaglia avevano fatto. È facile parlare della Palermo che ha saputo risorgere dalle ceneri della mafia, che si sta cercando – con grandissimi risultati – di vincere. Io volevo raccontare quella subcultura cittadina dove c’è ancora qualcuno che si fa spaccare le ossa, non solo in senso fisico. Volevo si capisse perché sia anche una culla di dolore e miseria, intesa non solo in senso materiale, ma di animo.
Diventa, a questo punto, imprescindibile fare un accenno anche a The Bad Guy, serie Amazon Prime Video che esce proprio oggi. Un appuntamento importante in questo tuo inteso periodo professionale. Ma che vede coinvolti anche tanti nomi che troviamo in Spaccaossa.
Certo. Siamo coinvolti io, Luigi Lo Cascio, Selene Caramazza, Aurora Quattrocchi. Anche lo scagnozzo che fa Biagio è parte del cast della serie.
Allo stesso modo, ambientata in Sicilia. Ma con un’altra tipologia di racconto. Che ti vede interprete di un personaggio ugualmente mostruoso, anche se con un tocco di ironia. Anche in The Bad Guy, però è forte l’elemento della mostruosità umana di cui ci hai parlato. E ritroviamo la volontà del cinema di oggi di riappropriarsi di un’altra Sicilia. Sta cambiando la narrazione della tua regione?
Assolutamente sta succedendo questo. Raccontando, come dici, in modo diverso, sia nei toni che negli accenti che vengono sottolineati. Io girerei mai nei modi in cui è stato fatto nella serie, ma mi è piaciuto farlo. All’inizio, ero un po’ restio. Poi ho conosciuto gli autori e registi di The Bad Guy, Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana. Ragazzi giovani, intelligenti a cui mi sono potuto accostare con grande rispetto. Per loro e il loro modo di raccontare. Perché ne comprendevo la necessità di raccontare, in fondo simile alla mia. Mi sono messo completamente a disposizione del loro lavoro. Quando abbiamo iniziato a girare la serie, stavo iniziando a lavorare su Spaccaossa. Ho anche sbirciato ogni tanto alcuni movimenti di macchina, alcune soluzioni sceniche che si stavano usando. Ma, insieme a loro, facevo le mie proposte e vedevo la loro intelligenza, la loro prospettiva narrativa sulla mostruosità. Per me, se Spaccaossa è il compendio della mia storia passata, in The Bad Guy mi sono ritrovato come invitato a casa di amici. Le scelte sono quelle degli amici, che ti fanno sentire coccolato. Come se fossi ad una festa.
Lavorare nel cinema, quindi, sa essere ancora una festa? Per la mia esperienza, sì. Non mi sono mai trovato su un set volendomene andare alla fine delle riprese. Sicuramente, con alcuni leghi di più e con altri di meno. Ci sono contesti in cui c’è un maggiore distacco. Ma mai mi è capitato finora di volere che quell’esperienza di set finisse. Anche nel rapporto con i grandi magisteri del nostro cinema per i quali ho potuto lavorare, mi sono sempre posto nell’ottica di dirmi che, sicuramente, dovessi farlo con grande cura e professionalità. Ma ho sempre saputo che il cinema fosse un serissimo e splendido gioco.
(Foto di copertina, come le altre dal Festival del Cinema di Porretta, gentilmente concesse da Federica Bettocchi)