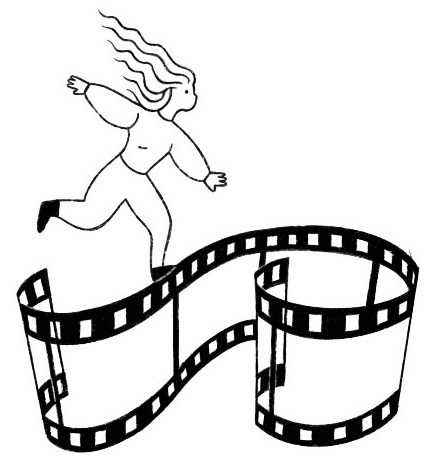La perfezione non esiste. È una frase fatta che l’uomo si ripete da millenni, quasi per rassicurarsi. Non importa la sua forza di volontà, il suo patrimonio monetario, l’organizzazione meticolosa della sua esistenza, nulla può assicurare la perfezione. Ci sarà sempre qualcosa di insoddisfacente, di discorde, di impossibile da controllare. Proprio per questo la comunità di Victory, un complesso residenziale nato per ospitare gli uomini che lavorano al progetto omonimo e le loro famiglie, dovrebbe sembrare un inganno fin da subito.
Le case colorate e piene di qualsiasi tipo di lusso, il tempo sempre soleggiato, nessuna preoccupazione derivata dalla mancanza di denaro o da qualsiasi altra situazione di malessere: Victory è la vita che i suoi residenti si meritano, come ribadisce più volte uno degli slogan più usati dalle pubblicità che riempiono il palinsesto televisivo. L’unica cosa che viene richiesta ai partecipanti al progetto Victory è la massima discrezione, specialmente verso le mogli, costrette a rimanere tutto il giorno in idilliache prigioni di intonaco. Non svelare le meccaniche del progetto significa non minacciare la felicità altrui. La giovane Alice (Florence Pugh), in seguito a un’incidente riguardante un’altra delle mogli, capisce che qualcosa non va e la realtà che il marito Jack (Harry Styles) prova a venderle non è altro che l’ennesima bugia.

Olivia Wilde, dopo il successo del suo debutto Booksmart nel 2019, torna dietro la macchina da presa per Don’t Worry Darling, un film estremamente più grande, ambizioso ma anche molto meno sincero e convincente del suo predecessore. Per tutta la giornata della sua première fuori concorso alla 79° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, era facile sentirlo paragonare a film come The Truman Show, Get Out o La Donna Perfetta oppure a un episodio poco riuscito di Black Mirror.
In effetti, il pretesto alla base di Don’t Worry Darling è qualcosa di già sentito, visto e ritrito dal mondo del cinema, specialmente negli ultimi anni. Questo non sarebbe un problema, se solo la sceneggiatura, firmata da Katie Silberman non finisse per ripetersi in continuazione per tutto l’atto centrale del film. La paranoia che dovrebbe permeare la distruzione dell’utopia distopica rappresentata da Victory finisce per essere dettata esclusivamente dalla frustrazione che lo spettatore prova nel vedere un film che non riesce a scappare da se stesso per poi arrivare frettolosamente a una conclusione estremamente prevedibile e contrita, che risolve solo alcune delle trame rimaste aperte.

Una delle poche certezze in Don’t Worry Darling è Florence Pugh, che viene chiamata di nuovo a interpretare una donna perseguitata da una comunità che non le crede in una sorta di sequel spirituale a livello tematico di Midsommar. Si tratta forse dell’unica scelta di casting convincente in tutto il film, dove anche attori capaci come Chris Pine, costretti ad occupare ruoli stereotipati, cadono facilmente nella caricatura. Don’t Worry Darling è un’occasione sprecata anche perché le scenografie di Katie Byron e i costumi, curati da Arianne Philipps (vincitrice del premio Campari for Passion), riescono a rendere reale Victory, prendendo ispirazione dall’immaginario pubblicitario degli anni ’50 e ’60, ma la sceneggiatura e la recitazione poco convincente svelano presto l’inganno.