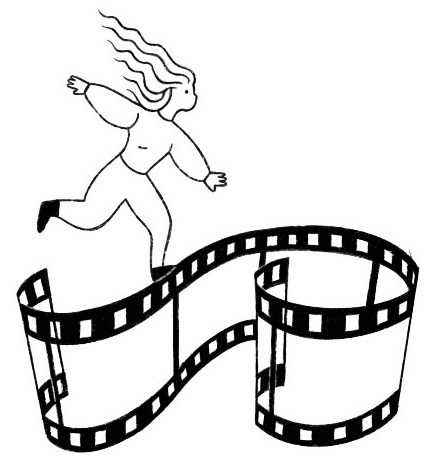Verrá presentato giovedí 2 marzo, alle 17.45 al Cinema Massimo di Torino e nell`ambito del nono Seeyousound International Music Festival, il film In the court of the Crimson King: King Crimson at 50 di Toby Amies.
Il ruolo dei King Crimson nella storia della musica
I King Crimson sono una chimera, animale composito e mai quieto. Sono un filamento di DNA, perennemente soggetto a cambiamenti, rimodellamenti, copie, trascrizioni e mutazioni, a volte benigne, a volte maligne. E nei King Crimson esiste un solo punto fermo: Robert Fripp. Despota insopportabile secondo gli ex-membri, in realtà uomo fragile e pieno di insicurezze, alla perenne ricerca di un qualcosa che non esiste.
Il suo wandering inizia nel 1969 e lo porterà solo a produrre capolavori: 13 album, suonati da 21 musicisti per un totale di 11 formazioni.
Fripp è un gentleman inglese perfetto, misurato, con una pronuncia degna di The Crown. Mentre parla sta in piedi o seduto, non gesticola, è egli stesso Re di un regno apocrifo inglese. La legge imposta è semplice, si ricerca il Peak, l’acme. In tutto. Nella performance musicale, nei tempi, nel canto e nel temperamento sul palco. Quanto dura il Peak? Un concerto, di solito, a volte un momento, o una canzone soltanto. È imprevedibile. E se non si raggiunge il Peak? Sarebbe come se morisse mia madre, dice Fripp. Il Peak è quindi una droga, che dà dipendenza, tolleranza e astinenza.

Il gruppo nel racconto del film
La scena spazia dal Re ai suoi vassalli, perennemente cangianti e con caratteri impossibili da accomunare: i solidi, materiali Gavin Harrison, Tony Levin e Pat Mastellotto, il redento Mel Collins, il timoroso Jakko Jakszyk, il tormentato Jeremy Stacey e, perla di questo film, il malato terminale Bill Rieflin.
Ognuno descrive i King Crimson come un mondo alieno, terribile e affascinante, dove si riconoscono a grandi linee temi terrestri (riff immutabili delle canzoni) e anche l’ingresso nella quarta dimensione: l’improvvisazione. Qui, come nella stanza barocca di 2001 Odissea nello spazio, c’è solo musica, i tempi spariscono, non c’è più one, two, three, four (nella migliore delle ipotesi) ma solo dum, dum, dum, dum, sguardi e istinti. Una apparente “indiscipline” che si risolve perennemente in una miracolosa “discipline”.

Discipline era il nome che voleva dare Fripp nell’81 al gruppo, ma quando Levin gli fece presente che in americano significava “punizione” tornò a King Crimson, in compenso chiamò l’album e la canzone tecnicamente più terrificante proprio Discipline.
La musica, come traspare guardando In the court of the Crimson King: King Crimson at 50, è intesa come sofferenza e dolore (Trey Gunn), sfida (Bill Bruford), senso di inferiorità (Jakszyk), cura e distrazione dall’inevitabile (Rieflin) e perfezione (Fripp).
E il pubblico? Da invitato alla mostra, non è il popolo suddito ma è esso stesso parte del palco a un solo patto: tacere, non filmare, non fare foto ma “abbracciare il momento” e “viverlo”.
La nostra recensione
Nel film manca molto: una cronologia precisa, una riflessione sulla scelta di suonare in terzetto, quartetto, quintetto, sestetto e ora praticamente una piccola orchestra da camera. Inoltre è totalmente assente la motivazione per i drastici cambiamenti di genere: rock, prog rock, jazz, classica, ancora rock, math rock, hard rock e blues.
Manca, insomma, quasi del tutto la musica, in favore di una visione intima e solitaria di ciascun musicista, che però, solo se condivisa con i pregi e i difetti del gruppo e del pubblico, può raggiungere il Peak.

Citati anche i grandi che non ci sono più, come il flamboyant Greg Lake e la voce celestiale del cantante nonché supremo bassista John Wetton, e ahimè molti altri. Sperando che loro possano ora essere perennemente nel Peak e, finalmente, si possano divertire.
Toby Amis, il regista, non si sofferma sulle successive scelte musicali del gruppo. Preferisce e insistere, a ragione, sulla durezza del lavoro di chi suona e di lavora per chi suona, trovando forse in questo ambito la sua chiave più convincente. Memorabili l’intervista all’anziano capo dei roadies, quelli che montano e smontano gli strumenti prima e dopo i concerti, mentre ci spiega che il suo non è un lavoro per vecchi. Sono responsabili della perfezione, così come i liutai che accordano le chitarre e le puliscono fino all’ultimo anfratto. Tutto in retropalchi impersonali, grigi e scomodi.
Certo, seguire il filo di questo film richiede uno certo standard di conoscenze, ma il messaggio chiaro netto che l’ottima musica è fatica e lavoro duro compensa e aggiunge spessore a un film forse imperfetto ma consistente.