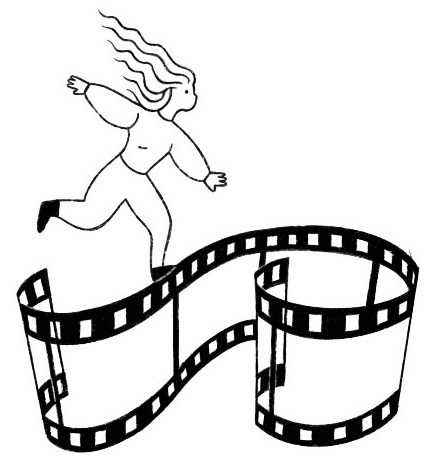Il Premio della Critica, assegnato dalla Giuria SNCCI presente al XXI Festival del Cinema di Porretta è andato a Rue Garibaldi, documentario generazionale di Federico Francioni.
Il Premio nasce a marzo 2021, quando AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema e SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, hanno siglato un protocollo che prevede la collaborazione delle due associazioni impegnate nella promozione, nello studio e nell’analisi del cinema attraverso l’istituzione del PREMIO DELLA CRITICA SNCCI da ospitare, con una giuria formata da tre critici cinematografici SNCCI, nei festival associati AFIC che ne facciano richiesta secondo un regolamento apposito.
Porretta Cinema ha voluto cogliere questa importante occasione di valorizzazione dei propri titoli per il concorso Fuori dal Giro e ha ospitato nel corso della passata edizione i tre critici cinematografici scelti per rappresentare il Sindacato e che decreteranno il loro proprio vincitore. Si tratta di Luisa Ceretto, Massimo Lechi e Alberto Tristano.

Tra i titoli proposti in concorso, a conquistare la giuria dei critici è stato il bel documentario Rue Garibaldi, di Federico Francioni, per il rigoroso e partecipe ritratto di una generazione divisa tra la ricerca di affermazione personale e le contraddizioni della propria identità culturale. Proprio a Porretta abbiamo incontrato il regista, approfondendo con lui alcuni aspetti sul suo film.

Oltre un anno di proiezioni, tra festival, rassegne e eventi speciali, per il tuo Rue Garibaldi. Un film che hai interamente prodotto e distribuito in autonomia. Quale il tuo bilancio a oggi?
Io mi sono lanciato in quest’avventura con l’urgenza di raccontare la storia di Ines e Rafik e fare il film ad ogni costo, anche senza nessun finanziamento. L’ho girato quindi con una certa incoscienza, credendoci molto, e l’ho montato da solo – la parte più difficile, piena di dubbi e incertezze. Il fatto che un film nato in queste condizioni sia riuscito a vincere premi importanti è semplicemente miracoloso.
Dopo un anno di proiezioni il mio bilancio personale è molto positivo, anche se la situazione generale non è affatto felice. I film, la bellezza e il lavoro di tanti autori c’è, ma in questo anno – anche per colpa del covid e dell’eredità con cui dobbiamo fare i conti – ho visto sempre più cinema e associazioni indipendenti, spazi di libertà, chiudere e arrendersi. Tutta l’ostinazione e la tenacia che si mette nel tentativo di proporre un cinema alternativo che non sia sempre e soltanto chiuso nella “nicchia cinefila” è spesso ripagato da un’indifferenza da parte del “sistema” che fa rabbia. Se investo un anno e mezzo della mia vita a raccontare un pezzo del nostro presente, costi quel che costi, e la bellezza di due ragazzi di 19 e 20, il mio unico desiderio è provare a raggiungere quanto più pubblico possibile: è questa l’unica cosa che dà senso al lavoro. E il pubblico, quando si riesce a raggiungere, è felice e partecipa! Ho ricevuto tantissimi messaggi anche da ragazzi giovani che mi dicevano di aver sentito molto vicina questa storia; proprio ieri sera una ragazza di un liceo a Porretta mi ha detto: “Questo film lo porterò con me”. Ed è questo il senso del lavoro, questo è l’atto culturale che fa esistere il cinema, e a cui non voglio rinunciare.
Purtroppo, a proposito di essere “fuori dal giro”, in Italia spesso si può ambire ad una dimensione pubblica soltanto se si fa parte di certi giri, e questo fa male. Ho passato tanto tempo a cercare di mettermi in contatto con personaggi pubblici, intellettuali, giornali, televisioni e critici che hanno un vasto pubblico, ma un film del genere per questo sistema non ha nessun valore – e tra l’altro, anche dopo il premio a Torino e dopo la notizia della shortlist dei David, distributori più o meno grandi continuavano a dirmi che il film “non è per la sala”, “non ha pubblico”, e via dicendo.
Alla fine ho dovuto andare da solo di città in città (lì dove ho trovato sale complici e accoglienti, ma anche su quel fronte si fa moltissima fatica) facendo sponsorizzazioni su facebook! Ma io so che la storia di Ines e Rafik potrebbe parlare a molte persone, emozionarle, e significare qualcosa. C’è come una soglia che non si riesce mai a sfondare del tutto, e quindi non si riesce mai veramente a fare del Cinema, ma siamo condannati a occuparci sempre di “grandi temi”, o fare “film difficili”, “documentari sociali”, “film di nicchia”: tutte categorie che rifiuto nettamente. Si fa Cinema per la voglia di condividere ed emozionare, di raccontare storie, e si può fare con una grande produzione alle spalle ma anche con un telefono e nella totale solitudine. Quello che conta è l’energia e la verità umana che c’è dentro. Il pubblico esiste, i film anche: gli intermediari spesso hanno abdicato al loro lavoro di ricerca. Le persone che ancora credono in un dibattito pubblico e nel cinema dovrebbero scrollarsi una certa pigrizia di dosso, smettere di accettare tutto quello che gli arriva “dall’alto”, già precotto, e mettersi in ascolto della bellezza che ci circonda! In questo i festival, quando funzionano e sono fatti con cura e amore, sono un aiuto fondamentale.

(Ph. Federica Bettocchi)
I ragazzi della giuria sono rimasti colpiti dalla storia dei tuoi protagonisti. Quasi immedesimandosi in loro. A te cosa è restato dell’incontro con Ines e Rafik?
Di questo incontro a me è rimasto tantissimo. È stato prima di tutto un rapporto di amicizia, quando ancora non erano i miei “protagonisti”, ma semplicemente due ragazzi giovanissimi pieni di energia, tenacia, contraddizioni, difficoltà e luce. Quando ho conosciuto Ines e Rafik mi sono sentito subito vicino a loro perché sono due ragazzi che contengono tantissime caratteristiche del nostro tempo e del nostro contemporaneo. E devo dire che sono stati anche d’esempio in molte cose. Quello che loro, così giovani, hanno affrontato – un mondo violento, precario e indifferente – e il modo in cui l’hanno fatto, mi ha dato anche una certa forza. Si sente spesso parlare dei giovani come dei fannulloni, invece qui avevo davanti veramente due macchine da guerra, che a vent’anni già lavoravano da dieci: erano ancora dei ragazzi, quasi dei bambini, e allo stesso tempo si confrontavano con un mondo adulto, maturo, molto duro. E la coabitazione di tutti questi stati mi affascinava molto. Poi c’era la questione della seconda generazione, alla quale ho deciso di non dare alcun peso perché per me la questione semplicemente non esiste. Questi ragazzi hanno un’origine tunisina, fa parte della loro cultura, e poi sono cresciuti in Italia, il loro modo di essere è impregnato della Sicilia: trovo tutto questo semplicemente meraviglioso, e parte della ricchezza umana. Mi sembra così scontato considerarli parte della mia famiglia, del mio paese, il problema non me lo pongo proprio (e, per inciso, trovo vergognoso che ancora dopo anni non ci sia una legge che certifichi qualcosa che fa già parte della nostra realtà!). Anche se, effettivamente, anche per alcune cose che mi raccontavano loro, non è stato facile crescere a Vittoria essendo “i tunisini” – anzi, la gente li chiamava “i marocchini”, perché lavoravano in un call center.
E quindi… ecco, anche per rispondere più chiaramente alla tua domanda, io mi sono immedesimato in tutto è per tutto con il loro modo stratificato e frammentato di stare al mondo, e con il loro senso di spaesamento che c’è, esiste ed è concreto, ma non perde il legami con le proprie radici, e cerca di mantenere ancora qualcosa di umano. Ines e Rafik per me sono riusciti a tenere tutto insieme, e trovo che il loro esempio sia molto forte.
Il Sindacato SNCCI ti ha conferito il loro premio al festival del cinema di Porretta. Che effetto ti fa un premio dato dalla critica?
Anche rispetto al modo in cui questo film è nato, un premio da parte del Sindacato critici mi rende assolutamente orgoglioso. Anche dentro una storia come questa, che poteva diventare facilmente un “racconto sociale”, o anche un film in qualche modo “troppo vicino” ai personaggi, troppo accomodante, ho cercato sempre di mantenere un certo rigore. Il Cinema è prima di tutto linguaggio, forma, e questo ho cercato sempre di rispettarlo e onorarlo. Soltanto attraverso la forma riusciamo a comunicare, e a “significare” in modo espressivo. E questo passa anche attraverso un lavoro molto molto duro sullo sguardo prima e in montaggio dopo, in cui si va a cercare “la cosa più considerevole”, l’essenziale per raccontare una storia, un volto, un essere umano cercando di mantenere sempre in vita quell’equilibrio molto precario tra qualcosa che è invisibile e qualcosa che è possibile in qualche modo disvelare, anche se per poco. E sono ancora più orgoglioso di questo premio perché riconosce che anche una “forma” documentaria – che spesso deve confrontarsi con la povertà dei mezzi e con i limiti della realtà – può essere considerato a tutti gli effetti Cinema: traiettoria narrativa, spazio simbolico, forma, partecipazione e condivisione, attraverso il linguaggio misterioso delle immagini. Quindi, ancora una volta, non posso che ringraziare il lavoro di tanti critici che si confrontano con questi lavori con cura e passione.

(Ph. Giorgio Barbato)
Uno degli elementi che i giurati hanno particolarmente apprezzato è stata la tua fedeltà al documentario in tutti i tuoi lavori. Cosa rappresenta per te e cosa te lo rende così funzionale?
Per me il documentario, o meglio la “forma” documentaria, o anche quello che si chiama cinema del Reale, rappresenta prima di tutto la possibilità di fare esperienze di vita, e di sperimentare una grande libertà nella forma. In un momento storico in cui spesso siamo circondati da storie e “prodotti audiovisivi” molto formattati, con degli standard prestabiliti, io penso che invece mettersi in ascolto in prima persona, uscire dalle zone di comfort e dai luoghi comuni e andare a cercare le storie, le traiettorie e le esperienze dentro la realtà, possa essere un grande valore. Poi non credo nella purezza del documentario; nel senso che stiamo parlando sempre e comunque di una costruzione, di una finzione, perché di mezzo c’è il linguaggio. Fare documentari significa spesso un enorme dispendio di energie, perché comunque la realtà senza filtri non basta di per sé, bisogna lavorarla, bisogna metterci un pensiero in mezzo, intorno, uno sguardo. Per il momento mi piace mantenere la possibilità di questo lavoro più libero ed espressivo, anche se molto faticoso – e dal punto di vista economico abbastanza insostenibile. Però l’avventura è sempre molto stimolante, e ricca di possibilità. E poi mi permette di mantenere una dimensione “intima”: al film lavoro da solo, o con alcuni amici che diventano complici, coi quali c’è uno scambio umano. Non c’è mai la grande “macchina” del cinema con i suoi tempi lunghi, e la sua “serietà”. Insomma, mi aiuta anche a non prendere sul serio questa attività e farla rimanere una bella avventura incosciente – al momento sto lavorando infatti a un progetto in Marocco completamente autoprodotto, e ancora dobbiamo inventarci ogni tipo di stratagemma per riuscire a girare in esterno senza farci arrestare! Poi un giorno mi piacerebbe anche confrontarmi con la finzione, magari portando con me queste esperienze dal Reale.
(Foto di copertina di Giorgio Barbato, per concessione di FCP2022)