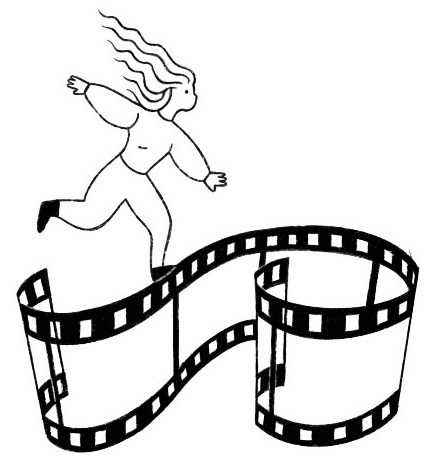Nell’ambito delle Giornate degli Autori e all’interno della sezione collaterale Notti Veneziane, Adriano Valerio a presentato la sua opera seconda Casablanca, tornando a seguire – dopo il pluripremiato cortometraggio Mon amour, mon ami, la storia dell’amore particolare tra Daniela e Fouad. Offrendo al pubblico una panoramica più completa su due vite ai margini, tenute in scacco dalla burocrazia e da una comunità che non riesce ad accettarli.
La trama
Fouad (Fouad Meiftah), figlio dell’Imam di un quartiere popolare di Casablanca, è clandestino in Italia da dieci anni, in attesa di cure mediche. Questo stato di limbo burocratico gli impedisce, da una parte, di sentirsi pienamente a casa tra le vie inospitali di Gubbio e, dall’altra, di provare una profonda nostalgia per Casablanca e per quella madre che teme di non riuscire più a rivedere. Daniela (Daniela Brandi) viene da una famiglia di esoteristi dell’alta borghesia pugliese. Ex tossicodipendente, vive in una grande solitudine. Allo stesso tempo, cerca una rivalsa personale e un modo per conciliare i suoi sogni con l’affetto e il legame inatteso che ha creato con Fouad nel corso degli anni.
Si sono conosciuti per caso in Umbria, e ognuno dei due afferma senza esitazioni che l’altro gli ha salvato la vita. Il loro incontro è l’inizio di un amore che guarisce al ritmo lento di stagioni e riti quotidiani, un luogo sospeso che danza nel tempo.
Con il passare degli anni però, Fouad si stanca di aspettare i documenti, stremato da un ambiente a cui sente di non poter mai appartenere.

Intervista al regista, Adriano Valerio
Come è nata la tua attenzione per questi due personaggi e come hai sviluppato il progetto di Casablanca
Il progetto è cominciato, oltre che dopo un incontro in un bar di Gubbio con Fouad durante la presentazione del mio primo lungometraggio (Banat – Il viaggio, 2016), molto presto. E il primo risultato è stato il cortometraggio Mon amour, mon ami. A quel punto, io pensavo di fermarmi lì. Per due ragioni. La prima perché il riscontro al corto era stato molto buono e mi sembrava che raccontasse in modo abbastanza coerente quel momento. Poi perché io speravo, in qualche maniera che, all’interno della loro comunità, il corto avrebbe permesso alle persone di conoscere meglio Fouad e Daniela, sui quali gravava uno sguardo molto diffidente e antipatico. In realtà, il risultato è stato esattamente l’opposto. Le foto condivise di loro due sul tappeto rosso sono state fonte di scherno ed insulti anche razzisti nei loro confronti.

Nel tempo, sono rimasto in contatto con loro, con i loro avvocati e assistenti sociali. Siamo rimasti molto legati. E sia il loro desiderio di continuare ad essere raccontati sia la necessità di sviluppare degli snodi delle loro vite che mi sembravano prestarsi in maniera perfetta anche drammaturgicamente mi hanno convinto a continuare.
Sei passato dal cortometraggio al lungometraggio. Come hai modificato il tuo rapporto con la storia in questo passaggio?
Dal punto di vista del dispositivo è sempre stato lo stesso. Nel cortometraggio si usa più voce controcampo, per concentrare più informazioni in uno spazio più ridotto. Mentre nel lungo, c’è meno voce controcampo e una parte più strettamente documentaria, con interviste, e un’altra in cui ho chiesto loro di reinterpretare scene realmente accadute nella loro vita. Non mi interessa, personalmente, definire cosa sia documentario e cosa sia finzione. Semplicemente, per me è importante che un regista sia onesto rispetto al suo dispositivo. Il mio, in qualche maniera è misto.
Non c’è mai stata un sceneggiatura. Dopo il cortometraggio, c’è stato un trattamento e, nelle tre sessioni di riprese che ho avuto a disposizione (nel 2016, una seconda nel 2019 tra Gubbio e Parigi e l’ultima a Casablanca), sapevo ci fossero dei punti che volevo toccare perché fondamentali per la drammaturgia e, proprio per questo dispositivo misto, seguivo un flusso di vite e situazioni. La scrittura del film si è fatta moltissimo in montaggio. In questo senso, quando Fouad era a Casablanca, ho capito che ci fosse un arco completo e potessimo fermarci lì e avere un film.

Quello che davvero questo film vuole trasmettere è il legame tra queste due persone, il fatto che, per loro stessa ammissione, si siano salvate la vita a vicenda, vivano l’uno per l’altro. Possiamo definirli una famiglia atipica, una coppia strana. Non mi interessa trovare una definizione. Sono due persone differenti, che arrivano da contesti improbabili e lontanissimi. Che si ritrovano a Gubbio e che vivono insieme per tre anni e si rendono conto che, grazie all’altro, è più facile sopravvivere alle angherie che li circondano.
Questo è il tuo secondo lungo dopo diversi anni in cui hai realizzato cortometraggi. Anche questo film nasce dal tuo legame con un tuo precedente corto. E lo realizzi in coproduzione con Sayonara, che ti aveva accompagnato nella distribuzione dei tuoi precedenti lavori.
Io voglio raccontare storie. Lo dico spesso, perché è vero che sono un caso atipico. E le storie sono divertenti, non divertenti, possono essere documentari o finzione. Io non capisco i colleghi che fanno un film che riescono a raccontare una storia ogni cinque anni. Con questo lavoro, non ho snobbato il lungometraggio. Prima di questo film ero già al casting di un film in Sardegna a cui tenevo e tengo tuttora. Ho in sviluppo e finanziamento un altro progetto. Ho girato anche una serie (Squadra criminale, 2017). Si è trattato in questi anni di una contingenza che mi ha portato a sviluppare le cose in parallelo.

La prima costante in produzione in questi anni sono stati i francesi Films Grand Huit e Dugong Films. Sayonara è entrata prima unicamente come distribuzione e adesso, in maniera davvero preziosa, hanno partecipato alla produzione sia del mio precedente cortometraggio che di questo film. E ne sono molto contento