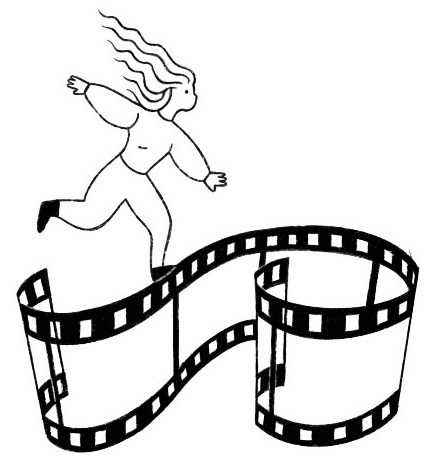Nel periodo della prima adolescenza uno degli antri segreti della scoperta sessuale è un gioco chiamato 7 minuti in Paradiso. Il presupposto è estremamente semplice: bastano due persone, di solito scelte con una precisa strategia dal gruppo di amici circostante, e un luogo chiuso come una stanza o in casi particolarmente audaci un armadio. L’obiettivo è di creare un’intimità forzata e magari di spingere i due suddetti soggetti a baciarsi o ad amoreggiare in altri mille modi. È una pratica bizzarra, figlia di rituali di corteggiamento antiquati e dei film americani, ma che in quel preciso momento dell’adolescenza appare non solo come un grande scandalo, ma anche come un luogo sicuro dove esplorare la propria attrazione verso l’altro perché nulla dovrebbe poter uscire da quelle mura.
I due protagonisti di Babygirl, Romy (Nicole Kidman) e Samuel (Harris Dickinson), spesso si concedono solo sette minuti. Sono degli incontri privati, parte di un programma di tutoraggio voluto dalla Tensile, una compagnia impegnata nell’utilizzo di robot per sostituire la manodopera e eliminare ulteriori posti di lavoro. Sono dei piccoli momenti, ritagliati a fatica nell’agenda di una CEO estremamente impegnata, per rispondere a dubbi o a qualsivoglia domande sull’azienda, ma presto si trasformano in uno spazio di esplorazione, dove essere liberi e poter lasciare le regole societarie fuori dalle mura della stanza.
Romy ha sempre avuto delle fantasie sessuali non-convenzionali, almeno rispetto all’immagine composta che la società ha di lei. Sposata da quasi vent’anni con il regista teatrale Jacob (Antonio Banderas), non è mai riuscita a raggiungere l’orgasmo con lui, per lei possibile solo guardando porno sadomaso. Quando si azzarda a chiedere al marito di lasciarle il cuscino sul viso mentre la tocca, Jacob si rifiuta presto spiegando che si sente un villano. Quando arriva Samuel, uno stagista carismatico e senza troppo pudore, Romy si arrende, scegliendo se stessa e il suo piacere per la prima volta nella sua vita.

Non è la prima volta che la regista di Babygirl, Halina Reijn, si interroga sul piacere nelle sue forme più controverse, difatti nel suo primo film, Instinct, metteva al centro una relazione tra una terapista criminale e un suo violento paziente. Qui la dinamica rappresentata è certamente più semplice e comprensibile al mondo esterno, una donna in una posizione di potere e un uomo più giovane ma capace di trovare una posizione di precario vantaggio nel gioco di desiderio che li lega.
Babygirl arriva in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia già vittima di una scelta pubblicitaria confusionaria. Paragonarlo ai thriller sensuali degli anni 90’ significa fare un incredibile disservizio al film, che finisce per essere – intenzionalmente o meno – più simile a una commedia che a titoli citati come ispirazione dalla stessa Reijn come Basic Instinct e The Piano Teacher. Babygirl funziona soprattutto quando riesce a spogliarsi, sia letteralmente che metaforicamente, liberandosi delle attese e di citazionismi vari per diventare una creatura a se stante, deliziosamente moderna e libera.
Il merito è soprattutto di un’intelligente scelta di casting che affianca Nicole Kidman, che si allontana finalmente dai ruoli televisivi a cui è stata relegata in questi anni in un film che finalmente le permette di abbandonare i panni della casalinga disperata per essere una donna che gioca con il potere e il successo in tutte le loro sfumature. Interessante anche la scelta di Harris Dickinson per il ruolo di Samuel, un attore che negli anni si è costruito un curriculum di tutto rispetto nel cinema indie (da recuperare soprattutto Beach Rats) e che arriva nel mainstream con un’incredibile potenza.
L’errore principale di Babygirl è quello di voler costruire un discorso più ampio, che va oltre Samuel e Romy, sui ruoli di genere e che cade spesso nella banalizzazione: a pari passo con il rapporto tra i due il film costruisce un confronto generazionale tra Romy e la sua assistente, Esme (Sophie Wilde), attraverso i loro ruoli nell’azienda e una mancata solidarietà emotiva. Sul piano teorico, l’idea di vedere due donne così diverse cercare di costruire la propria strada in un ambiente quasi del tutto maschile potrebbe approfondire un discorso sull’agency femminile, ma sul finire il tema risulta banalizzato e lasciato in disparte con un monologo dedicato al ruolo delle donne nell’azienda Tensile.